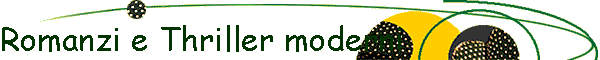
|
|
Fu da soprattutto da Edgar Allan Poe, Walpole, Mary Shelley, e pochi altri autori dell'Ottocento che nacquero i primi romanzi gotici, e di orrore, e presto si unirono a quelli psicologici per formare uno dei generi pi¨ letti e visti dei giorni d'oggi, la fortuna di artisti come Stephen King, o Michael Crichton, dai cui libri sono stati tratti film di enorme successo HorrorL'horror Ŕ un genere cinematografico che mira a suscitare paura nello spettatore. Se per Jean Cocteau il cinema Ŕ "la morte al lavoro", allora l'horror (in inglese "orrore"), che ha salde radici nella letteratura gotica sette-ottocentesca (vedi Poe), Ŕ il genere cinematografico per eccellenza, di volta in volta catartico o perturbante, fantasmatico o corporale. Le origini sono nel geniale e cupo gioco di ombre dell'espressionismo tedesco: il "doppio" faustiano di Lo studente di Praga (1913 e 1926, di Stellan Rye ed Henryk Galeen) e Le mani dell'altro (1924) di Robert Wiene, la leggenda ebraico-praghese del Golem (1914 e 1920) di Paul Wegener, l'incubo profetico in Il gabinetto del dottor Caligari (1919) di Robert Wiene, Nosferatu il vampiro (1922) di Friedrich Wilhelm Murnau, prototipo di ogni futuro vampiro su grande schermo. Fondamentale per l'iconografia del genere fu la morbosa sensibilitÓ nordica di Victor Sj÷strom (Il carretto fantasma, 1921) e le immagini di Carl Theodor Dreyer (Il vampiro, 1931). In America, meritato successo riscosse l'attore Lon Chaney, "l'uomo dai mille volti" di Il gobbo di Notre-Dame (1923) di Wallace Worsley e Il fantasma dell'opera (1925) di Rupert Julian. All'avvento del sonoro la macchina spettacolare hollywoodiana si appropria dei meccanismi luministici dell'espressionismo, producendo i grandi horror di scuola Universal: Dracula (1931, di Tod Browning, con l'affascinante vampiro di Bela Lugosi), Frankenstein (1931, di James Whale, con il mostro di Mary Shelley come inquietante marionetta postfuturista), La mummia (1932) di Karl Freund, dove l'horror si tinge di romanticismo. Tra i classici del periodo numerosi furono gli adattamenti letterari: Island of Lost Souls (1932) di Erle C. Kenton da Herbert George Wells, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde (1932 e 1941, di Rouben Mamoulian e Victor Fleming) da Robert Louis Stevenson, The Black Cat (1934), del maestro delle ombre Edgar G. Ulmer, da Poe, mentre King Kong (1933) di Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack Ŕ il primo di una lunga serie di mostri mutanti, che danno corpo ai timori di un progresso impazzito (come Godzilla, 1954, di Ishiro Honda e Il mostro della Laguna Nera, 1954, di Jack Arnold). Nel 1932 il gusto morboso di Browning approda a un punto di non ritorno per il genere, con lo sconvolgente Freaks, dove la poetica orrorifica della deformazione del corpo giunge all'estremo, attraverso la messa in scena di veri fenomeni da baraccone "buoni" in opposizione alla mostruositÓ deviante dei cosiddetti "normali". Gli anni Quaranta vedono alla ribalta l'orrore raffinato di Jacques Tourneur (Il bacio della pantera, 1942 e Ho camminato con uno zombi, 1943), sorretto da infiniti giochi di ombre fuoricampo, e nuovi esseri mostruosi, i licantropi (L'uomo lupo, 1941, di George Waggner), prefigurazione delle angosce adolescenziali di I Was a Teenage Werewolf (1957, di George Fowler Jr.); alla fine del decennio si afferma prepotentemente il binomio "sesso-sangue" in Eastmancolour nelle rivisitazioni dei classici dell'inglese Hammer Productions: La maschera di Frankenstein (1957) e Dracula il vampiro (1958) di Terence Fisher. All'inizio degli anni Sessanta emergono Roger Corman, efficace adattatore di Poe in Il pozzo e il pendolo (1961) e La maschera della morte rossa (1964) e la visionarietÓ colta di Mario Bava (La maschera del demonio, 1960; I tre volti della paura, 1963) e Riccardo Freda (L'orribile segreto del dr. Hitchcock, 1962), ma la vera novitÓ Ŕ rappresentata dal gore, la truculenza esplicita di H.G. Lewis (Blood Feast, 1963; 2.000 Maniacs, 1964) e barocca di J.M. Marins, maestro dell'horror brasiliano (Esta noite encarnarei no teu cadaver, 1966). Notevoli anche le incursioni nel genere di autori quali Hitchcock (Psyco, 1960, prototipo dei serial killer di Dario Argento, Profondo rosso, 1975, John McNaughton, Henry - Pioggia di sangue, 1990, e Jonathan Demme, Il silenzio degli innocenti, 1991), Powell (il voyeuristico L'occhio che uccide, 1960), Aldrich (il decadente Che fine ha fatto Baby Jane?, 1962), Polanski (il cerebrale Repulsion, 1965, e il demoniaco Rosemary's Baby, 1968), Friedkin (L'esorcista, 1973), De Palma (Carrie - Lo sguardo di Satana, 1976), Lynch (il visionario Eraserhead - La mente che cancella, 1977), Kubrick (Shining, 1980, vera summa orrorifica). La notte dei morti viventi (1968) e il suo seguito Zombi (1979), entrambi di George A. Romero, portano gli zombi nel cuore della societÓ dei consumi, mentre l'inquietante Non aprite quella porta di Tobe Hooper ne offre la controparte rurale. Gli anni Ottanta ribadiscono la centralitÓ del corpo come fonte d'orrore, grazie anche ai nuovi maestri del trucco (Baker, Bottin, Walas). Ecco quindi lo splatter ("schizzo di sangue") di Alien (1979) di Ridley Scott, L'ululato (1981) di Joe Dante,Un lupo mannaro americano a Londra (1981) di John Landis, La cosa (1982) di John Carpenter, Videodrome (1982) e La mosca (1986) di David Cronenberg, maestro di horror "esistenzialista". Notevoli anche il metahorror di Wes Craven (Il seme della follia, 1995; Scream, 1997), il neogothic di Tim Burton (Beetlejuice - Spiritello porcello, 1988), la new wave demenziale e cartoonistica di Sam Raimi (La casa, 1983; L'armata delle tenebre, 1992) e Peter Jackson (Bad Taste, 1987), l'horror "politico" di Brian Yuzna (Society - The Horror, 1989). Negli anni Novanta l'horror torna a essere un affare da major, con gli esercizi di stile di Francis Ford Coppola (Dracula di Bram Stoker, 1992) e Kenneth Branagh (Frankenstein di Mary Shelley, 1994) e con la malinconica immortalitÓ di Intervista col vampiro (1994, di Neil Jordan, dal romanzo di Anne Rice).
|