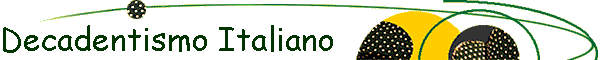
|
|
|
In Italia, dove la trasformazione economica in senso capitalistico avvenne in ritardo e in modo repentino, il decadentismo non assunse il carattere radicale e dirompente che ebbe nella vicina Francia. Diversa Ŕ soprattutto la concezione della figura del poeta, il quale mantiene una funzione di guida culturale della societÓ, al contrario di quanto avviene in Francia, dove MallarmÚ riconosce nell'isolamento la condizione del poeta, costretto ai margini di una "societÓ che non gli permette di vivere". Esemplare Ŕ la figura di D'Annunzio, poeta e letterato, ma anche uomo pubblico e straordinario precursore della moderna societÓ dello spettacolo (si pensi al gesto clamoroso del suo volo su Vienna, con il lancio di volantini tricolori), il quale, rimarcando la superioritÓ dell'intellettuale, si atteggia a vate e condottiero degli spiriti pi¨ nobili e arditi della nazione. Anche all'interno dell'industria culturale l'estetismo seppe trovare in Italia un suo spazio, affermandosi grazie a spettacolari manifestazioni e soprattutto oculate operazioni editoriali. Il suo centro fu Roma, dove l'editore Angelo Sommaruga fond˛ l'elegante rivista "Cronaca bizantina" (1881-1885); altrettanto importanti per la diffusione del decadentismo furono successivamente "Il Convito" (1895-1896), anch'essa romana, e la pi¨ longeva rivista fiorentina "Il Marzocco" (1896-1932). I maggiori scrittori decadenti furono, oltre a D'Annunzio (principale animatore della "Cronaca bizantina" e del "Convito"), Pascoli e Fogazzaro. Gabriele d'Annunzio rovesci˛ l'elemento aristocratico tipico del decadentismo in spettacolo da offrire al pubblico, in parte da recitare a beneficio delle masse. E lo fece creando anzitutto il mito di se stesso, l'intellettuale pi¨ celebre e chiacchierato dell'epoca in Italia. Egli tenne conto con grande tempismo delle esperienze letterarie straniere contemporanee sia in prosa sia in poesia. Cosý, se Andrea Sperelli, il protagonista del romanzo Il piacere (1889), rappresenta l'uomo raffinato e colto amante dell'arte e delle donne, Claudio Cantelmo impersona il superuomo nelle Vergini delle rocce (1895), mentre nel Notturno (1921) prevale un ripiegamento dell'autore su se stesso, assieme a una tematica pi¨ intima e riflessiva. La poesia di D'Annunzio, che teneva conto soprattutto delle esperienze francesi, divenne in breve il modello di riferimento (sia in positivo sia in negativo) della generazione di poeti contemporanea e di quella successiva. La sua sensibilitÓ straordinaria investe il mondo dei sentimenti, quello della natura e quello dell'arte, e la sua affascinante scrittura, ricca e suggestiva, ne costituisce la pi¨ appropriata traduzione in termini letterari. La poesia di Giovanni Pascoli rappresenta un felice tentativo di sprovincializzazione in senso simbolista, fondato su una realtÓ locale molto individuata, anche linguisticamente. Il poeta possiede una sensibilitÓ che gli permette di entrare in contatto con il mondo che egli canta senza mediazioni razionali o intellettuali, e la sua poesia rende conto di questa magica sintonia. Lo fa con termini molto precisi, anche di uso comune, con versi spezzati e interrotti, con una ricerca sul suono che vuole ridare la suggestione degli oggetti di tutti i giorni e degli ambienti modesti che sono la base della sua ispirazione. Il tentativo di conciliare la scienza con la fede cattolica Ŕ un motivo importante delle opere e del pensiero di Antonio Fogazzaro, che si interess˛ anche di occultismo e magia, tendenza, questa, contrastata dalla Chiesa, fino alla presa di posizione ufficiale rappresentata dall'enciclica Pascendi Dominici Gregis del 1907 contro il movimento modernista. Quello di Fogazzaro Ŕ comunque un cattolicesimo irrequieto, che convive con una sensibilitÓ a tratti morbosa. Le donne dei suoi romanzi sono spesso nervose ai limiti della malattia, instabili e volubili, impossibili da comprendere fino in fondo e perci˛ affascinanti. ╚ proprio la componente religiosa a dare profonditÓ alla rappresentazione del fascino femminile, l'emozione della tentazione inconfessabile ad alimentare la costruzione di personaggi come Marina di Malombra (1881) o Violet del Mistero del poeta (1888). Italia Anche in Italia il periodo fra le due guerre registr˛ una vigorosa rinascita del romanzo. Molto scrisse in quegli anni Carlo Emilio Gadda, che fra il 1938 e il 1941 pubblic˛ sulla rivista "Letteratura" il romanzo La cognizione del dolore (scritto nel 1936). Un altro capolavoro gaddiano, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, uscý dopo la guerra, nel 1957. Se Gadda elabor˛ un linguaggio di eccezionale varietÓ e complessitÓ, Alberto Moravia inaugur˛ nel suo libro d'esordio, Gli indifferenti (1929), da molti considerato la sua opera maggiore, un modello narrativo pressochÚ opposto, caratterizzato da un programmatico grigiore, nello sforzo di rendere anche stilisticamente lo squallore dell'Italia fascista. Non pochi scrittori italiani in quegli anni cercavano di elaborare un tipo di romanzo che sapesse conservare anche la densitÓ stilistica caratteristica della poesia, fondendo racconto e tensione simbolica: Conversazione in Sicilia (1941) di Elio Vittorini racconta un viaggio picaresco, lirico e simbolico verso le proprie origini materiali e spirituali. In una direzione analoga si mosse anche la narrativa di Cesare Pavese, elaborata negli anni Trenta, anche se le sue opere pi¨ importanti, quali La casa in collina (1948) e La luna e i fal˛ (1950), uscirono solo nel dopoguerra.
|