James Joyce
Nato a Dublino nel 1882 e morto a Zurigo nel 1941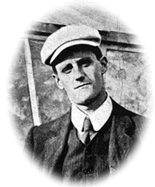 ,
scrittore irlandese.
,
scrittore irlandese.
Joyce esordì come poeta con Musica da camera (1907), 36 liriche d'amore che rivelano una forte sensibilità ritmica; e alla poesia sarebbe poi tornato nel 1927 con le tredici Poesie da un soldo. Nel 1918 apparve l'unico testo teatrale, Esuli, lavoro giovanile di sapore ibseniano. L'opera narrativa prese avvio nel 1914 con Gente di Dublino, quindici racconti, risalenti al decennio precedente, nei quali Joyce ripercorre le tappe dell'infanzia, dell'adolescenza, della maturità e della vita pubblica della sua città in momenti esemplari, capaci di cogliere – tra delusioni e insufficienze e senso di paralisi (che giustificano il suo "esilio") – attraverso folgoranti rivelazioni ("epifanie") di sapore simbolista, l'essenza interiore dell'individuo e della stessa realtà vissuta. Nel 1917 apparve Ritratto dell'artista da giovane (tradotto in Italia per la prima volta da Cesare Pavese nel 1933 e più noto col titolo di Dedalus). Di questo testo esiste una prima versione i cui ultimi capitoli, molti diversi rispetto alla stesura successiva, furono pubblicati postumi nel 1944 col titolo di Stefano eroe.
L'opera che diede fama internazionale a Joyce e che costituisce una delle più grandi interpretazioni dell'uomo contemporaneo è Ulisse (1922), ispirato all'Odissea di Omero. Il romanzo, in sostituzione delle peregrinazioni di Ulisse, racconta una giornata della vita dell'ebreo irlandese Leopold Bloom e, parallelamente, la stessa giornata vissuta da Stephen Dedalus, giornata che culmina nell'incontro delle due figure: Bloom si muove nell'inconscia e simbolica ricerca di un figlio, e Stephen, altrettanto inconsciamente, alla ricerca di una figura paterna che faccia da punto di riferimento alle sue inquietudini intellettuali. Ma il romanzo, che registra la realtà prevalentemente attraverso lo stream of consciousness di cui vivono i protagonisti (compresa Molly, la moglie di Bloom), tenta di presentare una summa degli aspetti dell'uomo moderno e insieme di rintracciare un filo, un ordine, dentro il caos anarchico della realtà contemporanea. Questo fondamentale romanzo della cultura occidentale apparve a puntate sulla rivista americana "Little Review" dal 1918 al 1920, quando la pubblicazione venne interrotta perché i contenuti furono giudicati osceni. La prima edizione completa apparve a Parigi nel 1922.
L'ultima e incompiuta opera di Joyce, La veglia di Finnegan (1939; il titolo originario, Finnegans Wake, allude a una ballata popolare irlandese), che può apparire caotica e in uno stadio di metamorfosi linguistica, è il tentativo dello scrittore di esporre in forma narrativa la teoria (vichiana) della ciclicità della storia quale intelaiatura profonda del reale. Intricati sono i percorsi mitologici e complesse le valenze simboliche del testo. A ciò si aggiungono le manipolazioni multilinguistiche che, nel loro incessante prodursi, conferiscono alla pagina l'aspetto di un magma in continua ebollizione di analogie, di concordanze, di interpretazioni e spiegazioni, di condensazioni e duplicazioni secondo la morfologia del sogno e dell'inconscio. Il romanzo descrive una serie ininterrotta di sogni compiuti da Humphrey Chimpden Earwicker nell'arco di una notte. Nell'evanescenza onirica, Earwicker e i suoi famigliari e conoscenti si fondono gli uni negli altri e in figure storiche e mitologiche, quali simboli dell'umanità intera.