Marcel Proust
Nato a Parigi nel 1871 e morto a nella stessa città nel
1922,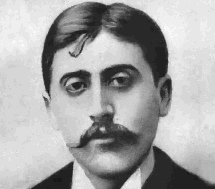 scrittore francese, autore del vasto ciclo narrativo Alla ricerca del tempo
perduto.La sua prima opera, I piaceri e i giorni
(1896), è una raccolta di saggi e racconti di ambiente mondano, che già
si caratterizza per la tendenza introspettiva. Tra il 1895 e il 1904 lavorò a Jean
Santeuil (opera scoperta e pubblicata nel 1952 dopo la morte di Proust), dal
taglio autobiografico nonostante l'uso della terza persona; questo romanzo
costituisce una prima prova della sua opera maggiore, la quale è invece in
prima persona ma con una forte presa di distanza dalla pressione autobiografica,
in sintonia con l'idea, maturata nel frattempo da Proust, che la felicità debba
essere ricercata nella scrittura e non nella vita. Negli stessi anni della
stesura di Jean Santeuil lesse John Ruskin, compiendo così un'altra
tappa fondamentale della sua formazione: Ruskin gli insegnò che la bellezza
dell'arte è superiore a quella della vita e, al tempo stesso, lo indusse ad
approfondire l'interesse per le arti figurative (a questo sono legati i pochi
viaggi che fece, in Italia, in Belgio e in Olanda). E di Ruskin tradusse alcuni
libri: La Bibbia d'Amiens, Sesamo e gigli.
scrittore francese, autore del vasto ciclo narrativo Alla ricerca del tempo
perduto.La sua prima opera, I piaceri e i giorni
(1896), è una raccolta di saggi e racconti di ambiente mondano, che già
si caratterizza per la tendenza introspettiva. Tra il 1895 e il 1904 lavorò a Jean
Santeuil (opera scoperta e pubblicata nel 1952 dopo la morte di Proust), dal
taglio autobiografico nonostante l'uso della terza persona; questo romanzo
costituisce una prima prova della sua opera maggiore, la quale è invece in
prima persona ma con una forte presa di distanza dalla pressione autobiografica,
in sintonia con l'idea, maturata nel frattempo da Proust, che la felicità debba
essere ricercata nella scrittura e non nella vita. Negli stessi anni della
stesura di Jean Santeuil lesse John Ruskin, compiendo così un'altra
tappa fondamentale della sua formazione: Ruskin gli insegnò che la bellezza
dell'arte è superiore a quella della vita e, al tempo stesso, lo indusse ad
approfondire l'interesse per le arti figurative (a questo sono legati i pochi
viaggi che fece, in Italia, in Belgio e in Olanda). E di Ruskin tradusse alcuni
libri: La Bibbia d'Amiens, Sesamo e gigli.
Nel 1902 morì il padre e nel 1905 la madre, con la quale aveva un legame particolarmente intenso. Intanto l'asma, di cui soffriva fin da bambino, divenne cronica e lo scrittore, trasferitosi sul Boulevard Haussmann, trascorse il resto della vita in una camera rivestita di sughero per proteggersi da ogni rumore. Nella solitudine, Proust riscoprì il valore del passato come luogo di irraggiungibile felicità. Iniziò così a lavorare al suo capolavoro, Alla ricerca del tempo perduto (1913-1927; il titolo francese è A la récherche du temps perdu), un ciclo di sette romanzi che narrano minuziosamente – in prima persona e in forma di monologo interiore – la vita e soprattutto le peregrinazioni mentali del protagonista, un uomo di mondo che si muove nell'elegante ambiente borghese. La prima parte, La strada di Swann (uscita per la prima volta in italiano nel 1946 con questo titolo, ma in seguito anche come Dalla parte di Swann), fu pubblicata nel 1913 a spese dell'autore e non fu capita. Vasti consensi (ne è prova il premio Goncourt) raccolse invece la seconda parte, All'ombra delle fanciulle in fiore (1919). Seguirono i due volumi di I Guermantes (1920-21) e i due volumi di Sodoma e Gomorra (1921-22), accolti anch'essi con favore. Le ultime parti, La prigioniera (1923), La fuggitiva (1925) e Il tempo ritrovato (1927), furono lasciate in forma manoscritta e pubblicate postume. Il protagonista tende a identificarsi con l'autore, così come altri personaggi corrispondono a persone realmente conosciute (ad esempio, Bergotte è Anatole France). Tuttavia Proust, nello scritto Contro Sainte-Beuve (1907), mette in chiaro la distanza e l'indipendenza dell'io biografico dall'io che scrive un romanzo, e questo ci aiuta a evitare il rischio di considerare la Ricerca un'autobiografia. La complessa struttura del romanzo, con zone oscure e continue diramazioni, corrisponde alla "ricerca" del romanzo da parte di uno scrittore che si propone con un io incerto e contraddittorio, sollecitato nella configurazione della realtà dalla vita di una memoria involontaria. A partire da eventi minimi, come nelle pagine iniziali il sapore della madeleine, un dolce gustato nell'infanzia, il protagonista fa riaffiorare un intero periodo della sua vita. Nella memoria il tempo, secondo l'insegnamento di Henri Bergson, è vissuto come durata, perché non c'è soluzione di continuità tra gli stati della coscienza e quindi la memoria è capace di abbracciare in una continuità solidale le trasformazioni cui il passare del tempo sottopone le cose, le persone e l'interiorità dei singoli. Inoltre Proust rappresenta ambienti e situazioni in modo diverso dalla tradizione realista, attraverso una soggettività dinamica che rende l'esterno simbolo della realtà interiore. Procedendo per questa via, fa apparire alla coscienza fenomeni inconsci, rimasti appartati o rimossi in un passato che la memoria involontaria porta alla coscienza con la forza e il sapore di un tempo. Un'altra direttrice della conoscenza di Proust è quella dell'analisi dei sentimenti umani più radicali quali l'amore e il senso di solitudine che si manifesta attraverso la gelosia (particolarmente analizzato, quest'ultimo, in La prigioniera). La ricerca espressiva di Proust si muove lungo i vasti circuiti di periodi lenti, prolungati, pieni di incisi, che mimano i meandri della disordinata e sprofondata realtà interiore in cui si vive la vita.